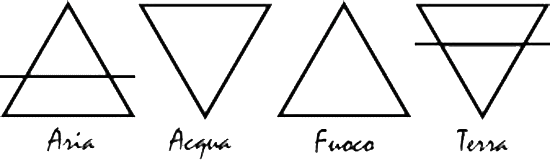L’ho amato di pancia. Un amore intestinale e sordo. Da quando non c’è più mi perdo nel suo ricordo, mentre i giorni trascorrono lenti e oziosi in attesa di un giudizio che ancora non è arrivato. Ci vorrebbe un giudice che ci assolva o che ci condanni. Non è un vero pensiero questo. Anzi è vero, ma non è plausibile perché non esiste un giudice che possa fare questo al posto nostro. Dovremmo condannarci o assolverci noi stessi, ma né io né lui riusciamo a farlo. Piuttosto difendersi, con tutte le armi e le parole a nostro favore, ma capitolare mai. Chissà se, dove si trova adesso, riesce a vedermi. Si parla tanto della vita dopo la morte, perché allora non potrebbe essere così come tutti dicono? La mia inclinazione allo gnosticismo mi spinge a sorridere di queste parole che non avrei mai pronunciato in passato. Ma quando la Certa ti passa accanto, salutandoti e ricordandoti che un giorno passerà anche per te, queste parole diventano consuetudine, e alla fine ci credi pure. Se fosse così, se davvero riuscisse a vedermi, vorrei chiedergli di giudicarci finalmente. Assolverci, condannarci, non fa alcuna differenza adesso. Anche questo però è un pensiero assurdo perché lui non c’è più e sono rimasta solo io in questo noi che ancora continuo a trattenere. Allora non rimane che a me il compito di giudicarci. Assolti o condannati? Chi sono io per farlo? E se ci perdonassimo? Ti perdono Gourias. E tu?
Sono seduta sulla panchina di legno della Villa Bellini, la stessa di sempre, mentre spio il cielo orizzontale che il mio sguardo perso nel vuoto riesce a catturare. Il cielo assomiglia al mare. Il suo colore, azzurro cristallino, riesce a penetrare dentro l’iride dei miei occhi, passa attraverso le pupille e s’inabissa in fondo al cuore, fino a pulirlo. Lo sciabordio del cielo-mare si eclissa tra i luoghi dei ricordi, ove il mio eremitaggio chiede adesso rifugio. Ed è proprio qui che riesco a vedere il suo viso, visione che ormai nella vita quotidiana si è fatta sempre meno trasparente, mentre qui incalza a ritmo crescente. Il cielo-mare adesso è dentro di me, e strappa dalle mie viscere la sofferenza trattenuta dalla ragione, arma chiamata in causa da un orgoglio che stenta a germogliare. La mareggiata imperversa sulle pareti dei miei organi interni, trascinando con sé livore, solitudine e amarezza. Detriti che questa giornata d’autunno seppellisce dentro il prato rorido di pioggia, sopra cui il peso della panchina crea uno squarcio invisibile o forse, solo un varco per l’inferno. Le gocce di pioggia appena cadute si sono attaccate alle suole dei miei stivali, amalgamandosi col terriccio, il quale profuma di ricci marini e acqua salata, camere d’albergo e vicoli nascosti. Ricordi che adesso sono seppelliti negli stessi cimiteri dove dimorano le nostre vecchie intenzioni, e quella parte di noi che porta il tuo nome. Qualche volta essi rivivono riesumando dalle tombe la stagione dell’illusione e dei luoghi in cui essa era solita intrattenersi. Quando i ricordi prendono vita nella mia testa, provocano un’emozione che si materializza nell’immagine dell’albero di Jacaranda, il cui tronco da qualche mese è circondato dai suoi stessi fiori morti. Di esso rimane solo uno scheletro: spauracchio degli affittuari e del barista che ogni giorno lo maledicono dagli angoli del Grattacielo. Cosa è capitato Gourias? Quando, dove e perché ci siamo incontrati per perderci?
Accadde d’autunno in una città morta. L’odore di piscio, dopo i violenti acquazzoni, esalava dai vicoli come il puzzo di certe puttane spossate dall’amplesso degli innumerevoli clienti in coda dentro le loro macchine ogni notte sul viale Africa. Due anni di sorrisi strappati, di baci rubati e di promesse mai mantenute. Anni che adesso sfrigolano sotto i piedi, mentre mi alzo dalla panchina per dirigermi verso il cancello della villa comunale. Ricordo il volto di quei momenti. Aveva lo stesso profilo della città e dei suoi abitanti: sporchi, maleducati e arroganti, i cui corpi trascinavano per le vie, i vicoli e le strade anonime. Riesco a sentire il calore e nello stesso tempo il gelo di quegli attimi, come Gourias preferirebbe chiamarli. Avevano con Catania lo stesso rapporto che hanno con lei i suoi abitanti: un amore infedele caratterizzato da un ardore simile a quello di un amante che tradisce i giuramenti per necessità, ma che poi torna ogni mattina al recesso clandestino per incontrare l’amata. Istanti spavaldi, chiacchieroni e a volte anche ottimisti. Quasi sempre strafottenti nello stesso modo in cui lo erano gli abitanti di quella città, un tempo soprannominata dai benpensanti la “Milano del Sud”.
Sto attraversando la villa comunale, e mentre lo faccio, mi perdo nel suo silenzio all’interno del quale accolgo il mio. Quello di adesso, di ieri e di domani. Un silenzio che si ostina a vivere in una città morta e dentro un cuore morto, dentro e fuori questo spazio aperto in cui ritorno ogni giorno per ricordare quegli anni di solitudine. Il giorno in cui l’illusione si fece disillusione, mentre stavo seduta sul marciapiede della fermata, aspettando il bus cittadino che sarebbe dovuto passare di lì a poco in via Etnea, una ragazza dall’aria semplice catturò la mia attenzione. Stava seduta anch’essa sullo stesso marciapiede. Mi guardò a lungo e io feci lo stesso. Se ne stava tutta sola e immobile: stava aspettando qualcuno, ne sono certa. Era l’ora di pranzo, e non c’era quasi nessuno in giro. Rimasi a guardarla per mezz’ora, poi, spazientita dall’attesa, andai a comprare alcune cose in un negozio ancora aperto a quell’ora, e pranzai al bar vicino. Dopo aver passeggiato per la via, in compagnia di un’amica incontrata per caso, decisi di ritornare speranzosa alla fermata per prendere l’autobus che mi avrebbe riportato finalmente a casa. Quando ritornai alla fermata, con mia grande sorpresa ritrovai lì la ragazza, sempre da sola, ferma allo stesso punto e con la stessa espressione di prima. Nulla era mutato in lei. Ed erano passate cinque ore.
Quella ragazza ero io. Penso spesso a questo episodio. A volte non riesco a credere di essere riuscita a vedere me stessa con gli occhi di un’altra persona. La me stessa morta in quell’istante è riuscita a staccarsi dal mio corpo per andare a fare acquisti, pranzare e passeggiare con una amica, mentre la me stessa ancora illusa rimaneva seduta sul marciapiede ad aspettare qualcuno che non sarebbe mai arrivato. La cosa peggiore è che la me stessa morta aveva i capelli bagnati di pioggia e il viso fradicio di lacrime. Da quella giornata di marzo, la mia anima è rimasta seduta su quel marciapiede. La mia mente invece si è rifugiata dentro quel tappeto di fiori raffigurato nell’immagine che appare sempre quando mi siedo su quella panchina della Villa Bellini.
Se l’illusione fosse un mese, sarebbe novembre, mese in cui credetti di essere amata, per poi scoprire solo più tardi che si trattava di un inganno. Se avessi potuto scegliere in quella giornata di marzo, avrei scelto l’autunno per morire sui visi dei passanti e sulle loro mani, sulle giacche e sui pastrani, sui cappelli anti pioggia, sugli ombrelli spiegati e le felpe di cotone pesante, proprio come sono morta in quel giorno di marzo.
Mi trascino fuori dalla villa Bellini, i cui cancelli sono stati semichiusi da poco dal custode. Lancio un ultimo saluto alla panchina, e mi dirigo verso piazza Stesicoro. L’odor di castagne si diffonde dentro l’anfiteatro romano, adagio.
Si è fatto tardi, adesso. Buio pesto intorno a me. Buie le vie che portano a casa. L’odor d’autunno, gattonando su per le scale dell’incoerenza, si diffonde in echi e rintocchi di saecula saeculorum:
Su per la schiena,
Sudata come Edera
Umettata di pioggia,
Unghie e nocche duellano.
Amore brama…
Psiche si concede
E frena appena il curioso assillo
Trattenendo il respiro.
Alle sue membra arresa,
Adesso effluvio in grembo
Di speme abbonda.
Noctu concubia
Aedes plangoribus
Et gemitum resonat
graffiandomi, infine, la pelle.
In questo spazio presente, in questo qui e ora, Gourias è accanto a me. Posso sentire il calore della sua mano destra che prende la mia sinistra. Riesco a sentirci camminare accanto, e camminarci dentro come fantasmi che vagano addormentati in questa Catania morta come allora. La sua città, non la mia. Catania lo tiene nel suo grembo morto, esangue e scivoloso.
Lo invito a stringermi la mano, mentre passo sotto casa sua. La libreria, sorta poco dopo il nostro incontro, resiste ancora agli attacchi dell’ignoranza. Mi sembra di sentirlo mentre, con un impaccio studiato e sotto controllo, mi dice che “L’amore ai tempi del colera è forse uno dei più bei libri scritti da Marquez. Sicuramente uno dei più riusciti!”. Se penso che Gabriel Garcia Marquez è morto un anno prima di lui, mi scendono lacrime amare dagli occhi. L’associazione mentale libreria-Marquez è d’obbligo adesso che io e lui entriamo in libreria, fianco a fianco, scorrazzando da una parte all’altra di questo rifugio di parole, di copertine, di nomi e di comparti, alla ricerca del nostro libro. La sua mano nella mia, la sua giacca rossa sulle mie spalle, e i suoi occhi sul mio collo.
“Raccontami un libro, Gourias, vuoi?” lo imploro come farebbe una bambina che vuole ascoltare una fiaba. Il signore barbuto che fa il cassiere in libreria mi chiede se voglio una busta per il libro. Gli faccio cenno di sì e mi appresto a pagare. Il cassiere mi dà lo scontrino, e poi sussurra pensando di non farsi sentire: “Però! Devo ricordarmi di comprarlo anch’io”. Io e Gourias salutiamo il signore con la barba e ci rimettiamo a camminare sul marciapiede di via Etnea.
“Va bene va bene. Ti racconto una storia! Sei contenta?” sbotta Gourias senza lasciarmi mai la mano.
“Sì, vai. Ti ascolto” gli dico sorridendo.
©Anna Nais 2018/ tutti i diritti riservati